Molfetta, il prof. Voza alla "Casa dei Popoli" ha ricordato il dramma dell'ultimo Pasolini
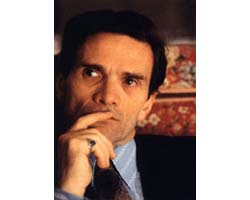
MOLFETTA – 3.11.2005
Cogliendo l'occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Pier Paolo Pasolini (nella foto), si è tenuta ieri sera una conferenza dal titolo "Il corpo, il sacro, il moderno:Il dramma nell'ultimo Pasolini" presso la Fabbrica di San Domenico, tenuta dal prof. Voza, docente di letteratura italiana all'Università degli Studi Bari, a cura della “Casa dei Popoli”. A moderare il prof. Alberto Altamura.
Pervaso da una notevole dose di verve accademica, il prof. Voza ha cercato di dare forma con le parole alla vasta opera pasoliniana, e poetica, e romanzesca, e cinematografica.
Nonostante il difficile compito, ha tentato di fornire un quadro esaustivo dei temi cardine e cari a Pier Paolo Pasolini: la presa di coscienza dello smembramento antropologico dell'uomo degli anni 60-70, appiattito in un'unica dimensione, quella marcusiana, dell'uomo prodotto, attratto e mosso solo dalla sfrenata voglia di consumo. La scomparsa del sacro nella vita degli uomini del suo tempo, la necessità e la voglia di recuperare il “corpo”, quella corporeità ormai inghiottita dall'uomo “borghese” che non è ormai niente più che una falsa ombra di sé.
Pasolini disegnato come una forma poetica di “Impotenza della grandezza e grandezza dell'impotenza” al contempo. E non solo, come un fiume in piena, come chi sa che il tempo a disposizione è davvero esiguo rispetto alla mole di contenuti da dover trattare, il prof. Voza ha proseguito il racconto toccando anche gli aspetti della critica a Pasolini, quella rivoltagli ad esempio da Italo Calvino, grande scrittore del '900 italiano, che lo criticava perché vedeva in lui soltanto la presenza di un dramma, quello del rimpianto di un tempo passato che non torna, della famiglia patriarcale, quello della vita semplice e contadina degli italiani, imborghesiti poi dall'avvento del miracolo economico. E l'impossibilità quindi di vedere altro se non questo presente pervasivo e nulla più.
Pasolini, diceva egli stesso, amava dialogare con chi non avesse nemmeno fatto la quarta elementare, perché l'assenza di sovrastrutture borghesi rendeva il dialogo con quelle persone più piacevole, perché più vero, meno staccato dall'uomo quale dovrebbe essere.
Per questo Pasolini si “nasconde” scrivendo a “Gennariello” (Lettere Luterane), un ragazzo immaginario che gli permette di sublimare i temi a lui più cari. Gennariello è napoletano, perché a Pasolini la napoletanità piace, perché qui vi scorge l'unica forma di realtà non cristallizzata dall'imborghesimento del tempo. La discrasia realtà-idealità, è sublimata nell'opera pasoliniana attraverso quella che il prof. Voza ha definito “Iunctura Ossimorica”: l'unione degli opposti realizzabile solo in ambito artistico e letterario.
“Non pensiate che Pasolini debba darci uno sguardo sul mondo, non dobbiamo indossare le sue lenti, non dobbiamo guardare alle tracce profetiche delle sue opere […],” - ha risposto il prof. Voza ad alcuni interventi dal pubblico – “la bellezza dell'opera pasoliniana sta invece nella possibilità che abbiamo di osservare il suo mondo con i suoi occhi. Perché la vera cultura non è qualcosa di organico al sistema, bensì disorganica al sistema. A priori, statutariamente”.
Pasolini cercherà sempre quel Gennariello, nella vita di tutti i giorni. Anche quella sera di trent'anni fa Pasolini cercava in Pelosi, Gennariello: a tutti è noto il tragico epilogo.
Massimo Bufi